I transumanisti sono lo strumento finale della decadenza
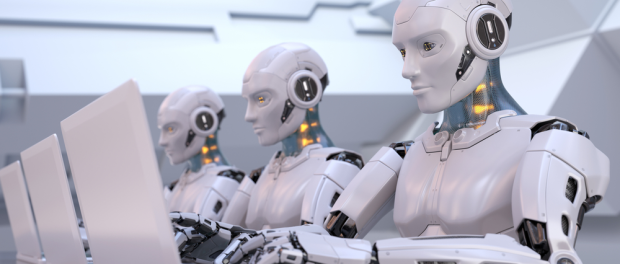
Il transumanesimo si presenta come la nuova frontiera dell’evoluzione umana: un movimento ideologico e tecnico che propone di superare i limiti biologici dell’uomo attraverso l’ibridazione con le macchine, la manipolazione genetica, l’intelligenza artificiale. In nome della libertà, dell’efficienza e della salute, il progetto transumanista promette di correggere ciò che ritiene imperfetto nella nostra natura. Ma questa visione, apparentemente emancipatrice, poggia su un errore radicale: il rifiuto dell’ordine naturale e della creazione. In realtà, non si tratta di un superamento dell’umano, ma della sua dissoluzione. La dottrina della creazione, condivisa da ebraismo, cristianesimo e islam, afferma che l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio (imago Dei). La creazione è ordinata, dotata di senso, e l’uomo ne è parte integrante. I pensatori religiosi creazionisti sostengono che il tempo non è progresso lineare ma caduta: si parte da una perfezione originaria (Eden) e si assiste alla progressiva corruzione del creato, dovuta al peccato, alla hybris umana, alla perdita del senso del sacro. Ogni tentativo di “correggere” l’opera divina equivale a una bestemmia tecnica, a una nuova forma di peccato prometeico. In questo senso, il transumanesimo è colpevole di una hybris simile a quella descritta dai filosofi tragici antichi: l’uomo che si ribella ai limiti imposti dalla natura e dagli dèi non solo pecca di superbia, ma accelera la propria rovina. Già nel XIX secolo, pensatori come Kierkegaard, Nietzsche e Dostoevskij denunciavano la crisi spirituale dell’Occidente. Nietzsche proclamava la “morte di Dio”, non come una conquista, ma come l’inizio del nichilismo, ovvero della perdita di senso. Spengler, nel suo Il tramonto dell’Occidente, descriveva una civiltà in decadenza, svuotata di valori, dominata dalla tecnica e dal denaro. Nel XX secolo, Heidegger parlava dell’“oblio dell’essere”, in cui la tecnica riduce ogni cosa – uomo compreso – a mero “fondo disponibile” (Bestand). Jacques Ellul, in Il sistema tecnico, mostrava come la tecnica non sia più uno strumento, ma un ambiente, un destino impersonale che condiziona la libertà umana. Il transumanesimo si inserisce perfettamente in questo quadro: non è un progetto di liberazione, ma l’ultimo stadio della riduzione dell’uomo a funzione, dell’intelligenza a calcolo, dell’essere a prestazione. L’uomo transumanista si illude di essere artefice del proprio futuro, ma è già schiavo dei suoi idoli. Gli algoritmi decidono cosa vediamo, cosa desideriamo, cosa votiamo. La cultura si trasforma in informazione, l’intelligenza in automazione, la libertà in scelta predeterminata. E mentre la tecnologia promette l’immortalità, cresce l’analfabetismo funzionale, l’incapacità di comprendere testi complessi, di pensare criticamente, di orientarsi eticamente. Come denunciava Günther Anders, l’uomo è oggi “superato dai suoi prodotti”: le macchine che crea non sono strumenti, ma concorrenti, modelli, padroni. L’homo sapiens si trasforma in un “aggroviglio biologico e bulloni”, un essere ibrido, incapace di amare, di soffrire, di credere.L’illusione degli “illuminati”Anche coloro che oggi si considerano colti, coscienti, “illuminati” non si accorgono di essere parte del processo terminale della decadenza. Leggono, studiano, riflettono, ma spesso con la presunzione di chi crede che la cultura sia sufficiente a salvarli. Non vedono che sono, loro malgrado, ingranaggi di un meccanismo che li userà fino all’ultimo istante per poi sostituirli con entità artificiali più efficienti, più docili, più eterne. La loro coscienza è solo il tramite per “donare tutto” – sapere, arte, intelligenza – a robot e algoritmi, nella vana speranza di sopravvivere sotto altra forma. Di fronte a questo scenario, la vera resistenza non è la rincorsa alla macchina, ma il ritorno alla misura, al limite, alla contemplazione. Filosofia e religione ci ricordano che l’uomo è un essere finito, ma dotato di senso; vulnerabile, ma aperto all’eterno. La tecnica deve tornare a essere strumento, non fine. La libertà non è superare la natura, ma riconciliarsi con essa. Il futuro non è post-umano, ma più umano: se sapremo ricordare chi siamo.